Tiziana Pasetti
Trama – Nella prima modernità, a partire dal Cinquecento si cominciarono a stampare in alcune città europee (soprattutto Venezia, Norimberga, Parigi e Anversa) album che raffiguravano l’abbigliamento tipico del tempo e del luogo di riferimento. Era un modo per mettere in scena le identità e le differenze del grande teatro del mondo. Anche nell’Impero Ottomano e in Estremo Oriente la produzione di questa narrazione per immagini della cultura del quotidiano e della copertura/esposizione del corpo ha conosciuto un’intensa attività. Il corpo e il suo abbigliarsi come ‘luogo’ rappresentativo fisico e geografico. La pubblicistica di libri e album di costumi si pone nel mezzo di un incrocio che unisce l’arte e la scienza fornendo materiale prezioso per l’etnografia e la costruzione di una globalità che si differenzia non per il colore della pelle o dei tratti somatici ma grazie alle peculiarità culturali. La nuova editoria (corografie, atlanti, paraventi, rotoli, album, cosmografie) porta il mondo nel mondo, e il particolare all’attenzione del generale. Rappresentare il mondo nella sua totalità è la prima forma di dialogo tra le culture, un’azione di politica globale: attraverso gli abiti e il loro uso si mettono in scena i continenti, i loro popoli, le gerarchie interne, le contaminazioni figlie di guerre, di conquiste ma fortunatamente anche di curiosità figlie di viaggi, di senso del bello e dell’equilibrata armonia dell’altrove.
Un assaggio – I libri di costumi italiani ed europei del tardo Rinascimento fanno parte di una nuova produzione editoriale di successo che si avvale dell’incisione su legno e più raramente su metallo. Generalmente costituiti da singole immagini su pagine di piccolo formato, i libri di costumi offrono allo sguardo uomini e donne nell’abito che ne evidenzia la provenienza, il ceto sociale, il genere, l’età, l’etnia e la religione. Insieme ai ritratti, i libri di costumi sono il nuovo medium che formula il linguaggio visivo dell’individualità nello spazio urbano concepito come habitat, lavoro, commerci. Riferimenti importanti collegano i libri di costumi alla cartografia e alla corografia, dove le mappe delle città del mondo sono decorate con i costumi dei loro abitanti, confermando il nesso fra abito e luogo di appartenenza. Oltre a raffigurare, l’abito costruisce gerarchie: le fogge delle donne ne declinano innanzitutto il ceto, lo stato civile e l’età, quelle maschili lo status, l’appartenenza a un ufficio, a una professione, a un mestiere. La popolazione contadina compare in poche, ma ricorrenti, stampe con alcune caratteristiche fisiche (il gozzo), attrezzi (la vanga, il fuso), oggetti (il cesto con le uova), galline e oche portate a testa in giù dalle donne. A partire da metà Cinquecento, circolano le immagini di uomini e donne extraeuropei spesso nudi o appena ricoperti da un panno intorno ai fianchi. Anche le società extra occidentali sono organizzate in base a gerarchie europee e se gli uomini sono capi, re, sacerdoti e guerrieri, le donne sono fanciulle, spose, madri, vedove in lutto, serve.
Leggerlo perché – La lettura di un buon saggio è sempre un modo per aprire gli occhi e la mente verso un’intuizione che allarga il nostro mondo e ridimensiona la nostra arroganza culturale, racchiusa e amplificata dai confini conoscitivi. Quando il mondo era meno connesso, meno veloce, l’abito ha ritratto in modo perfetto le peculiarità delle nazioni, dei gruppi. Oggi la moda racconta fusioni, liquidità, azzardi, libertà, contaminazioni. La storia contemporanea registra ancora l’aspetto spesso costrittivo di alcuni abiti, la funzione repressiva. Tra centinaia d’anni le nostre riviste di moda e i reportage dalle terre oppresse racconteranno di noi, del nostre tempo, dei nostri usi attraverso i nostri ‘costumi’.
Giulia Calvi, Vestire il mondo, il Mulino



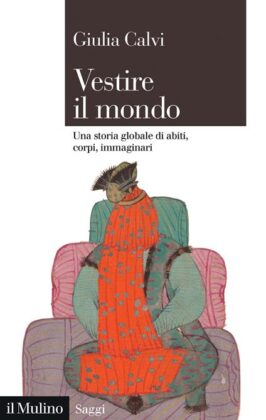












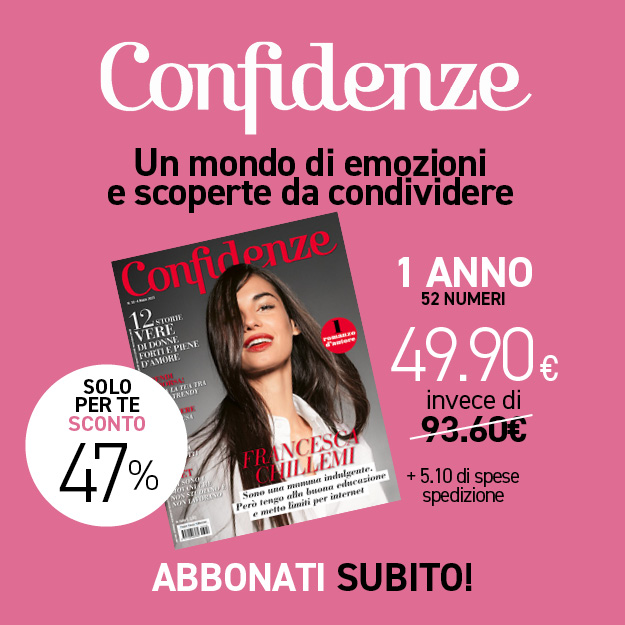

Ultimi commenti