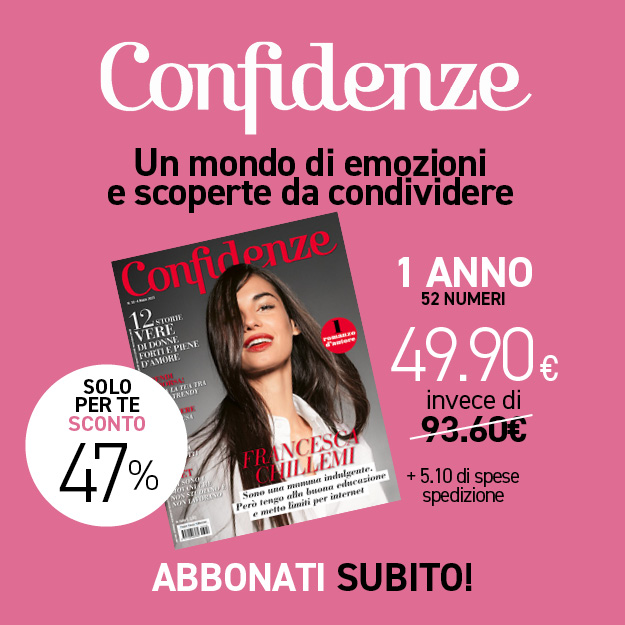È in quel momento che comincio a pensare alla bicicletta come mia compagna di avventure: al rientro in Italia, dopo aver lavorato in Toscana nella raccolta delle cipolle, comincio a organizzare il mio prossimo viaggio, questa volta in sella alla bici. I miei genitori mi appoggiano in tutto, non abbiamo problemi economici e non devo lavorare per necessità, ma lo sento come imperativo morale, visto che ho superato i 20 anni. Soprattutto, so che devo saziare una voglia di conoscenza che a scuola ho solo immaginato.
L’occasione arriva a gennaio 2024 quando devo partire per l’India, per un soggiorno studio. Destinazione Nuova Delhi, in uno dei campus più ricchi del paese: è un ambiente asettico, molto lontano dalla vita reale che brulica fuori. È il momento giusto per portare con me la bici con cui rientrare a soggiorno finito. Sono elettrizzato all’idea, forse troppo: a cinque giorni dalla partenza, mentre pedalo nei vicoli bolognesi, cado rovinosamente, rompendomi il braccio sinistro. Ingessato, non riesco a portare con me zaino, trolley e bici. Ammetto di aver pensato per un attimo di mollare, ma poi ho capito che c’era un’alternativa: sono partito, pronto a seguire la fisioterapia in India, ma senza bicicletta che avrei acquistato lì, mentre il casco, le sacche laterali, il telaio, lo avrebbero spedito da Milano i miei genitori. Ed è andata proprio così: sono volato da Nuova Delhi in Kazakhistan, a circa 50 chilometri dal confine cinese. Con me, la mia compagna di avventure, acquistata grazie al contributo del campus indiano, affascinato dal mio progetto: la bicicletta. Ho iniziato a pedalare attraversando la steppa e già dopo i primi metri sul terreno brullo, ho avvertito un senso di libertà difficile da spiegare. Intanto mi ero alleggerito del trolley e di parecchi abiti, regalati al receptionist dell’ostello in cui ho dormito per l’ultima volta, prima che il mio letto fosse la tenda, da montare sempre in zone protette. Quello che non sapevo è che in tanti mi avrebbero ospitato: in tutta l’Asia centrale gli italiani sono amati incondizionatamente, grazie, probabilmente, anche alla cultura musicale di Cutugno, Celentano e Albano, conosciutissimi da tutti. Nessuno parlava inglese, ma solo il russo e i dialetti locali, eppure ho comunicato con quella gente di cui conservo stampati nella memoria i volti e i sorrisi: a gesti e non senza grandi risate. Palatka, che significa tenda, è effettivamente la parola che più di qualche volta mi ha aiutato nei momenti di incomprensione! Ricordo due signori anziani che mi hanno fatto dormire nell’uscio della loro casa offrendomi un pezzetto di formaggio caprino molto buono; altri mi hanno fatto montare la tenda in giardino e mi hanno regalato un po’di frutta. Tutti sono stati estremamente ospitali.
Certo ho dovuto anche adattarmi: in Asia centrale non ci sono bagni degni di questo nome, ma piuttosto buchi nel terreno o al massimo wc di legno! Il mio doccino portatile da 10 litri è stato provvidenziale. In Kirghizistan ho raggiunto i 3200 metri di altezza, avendo davanti a me un orizzonte che sembrava infinito. Di lì, finalmente, sono arrivato in Tagikistan, percorrendo la Pamir Highway, strada prevalentemente sterrata dove ho toccato i 4670 metri sul livello del mare. È stato molto faticoso, ma anche bellissimo riuscire a farcela: a volte ho dovuto spingere la bici, perché l’aria rarefatta non mi aiutava. Ho incrociato poca gente e pochissimi villaggi e per giorni ho mangiato pane e uova e al massimo della marmellata: trovare della frutta fresca era impossibile, nessuno la porta fin lassù. Raggiungere e superare quel punto era la paura più grande che avevo, anche perché, nonostante fosse primavera, è frequente trovare la neve e temperature rigidissime. Inoltre, non sapevo se sarei stato capace di riparare eventuali danni alla bicicletta e questa paura, devo ammetterlo, mi ha paralizzato quasi quanto i cani che più di una volta mi hanno rincorso. E poi c’è un altro aspetto che avevo sottovalutato: ero sempre solo, in compagnia di me stesso e di nessuno più. Anche per questo occorre essere preparati, perché lo sconforto può prendere il sopravvento. Ho provato un brivido quando ho costeggiato il fiume che separa il Tagikistan dall’Afghanistan: tra una sponda e l’altra a volte c’erano poco più di 50 metri e in lontananza riuscivo a vedere i villaggi senza elettricità, la gente con gli asini e, purtroppo, i pickup dei talebani.
Quando ho finalmente raggiunto la capitale, Dušanbe, mi sono imbattuto in una città ordinatissima e deserta: i palazzi maestosi non sono alla portata della gente che vive in periferia, sotto una rigida dittatura. L’Uzbekistan con la coloratissima Samarcanda mi è sembrato quasi familiare: la gente è abituata ai turisti e qualcuno parla un po’ di inglese. In Azerbaijan sono arrivato in aereo perché dopo la pandemia non era più consentito entrare via terra: l’ultimo Paese prima di avvicinarmi all’Europa è stato il più autentico. Nonostante la gente umilissima, ho trovato l’accoglienza migliore. Un signore mi ha fatto dormire nella sua casetta e mi ha offerto una cena che ancora oggi mi fa emozionare: pane, uova e cetrioli. Era tutto ciò che aveva.
Ho continuato a pedalare verso ovest, fino al confine con la Georgia: 550 chilometri in cui non ho incontrato nessun turista ma solo gente del posto, pronta a incoraggiarmi con affetto. Finalmente in Turchia, ho ricevuto quasi un tifo da stadio e ho conosciuto Amir, un giovane pakistano anche lui patito di bicicletta, che mi ha offerto il pranzo e la cena e mi ha permesso di fare una lavatrice in casa sua. La prima tappa greca è stata Kastellorizo, dove un amico mi ha ospitato per la prima breve vacanza dopo giorni di fatica: non mi sembrava vero poter dormire su un letto e non in tenda! Ho goduto della bellezza dell’isola, da cui ho raggiunto Atene in traghetto, pronto a ripartire per risalire lungo i Balcani. È stato l’ultimo sforzo, a tratti difficile per il traffico incontrato man mano che mi avvicinavo alle mete più turistiche: in Croazia, per esempio, Paese che ormai attira un turismo medio alto, non ho trovato empatia, cosa invece che mi ha accompagnato nelle zone più povere. Sono arrivato a Milano dopo sei mesi dalla mia partenza ingessata: ho pedalato per 57 giorni e percorso 6500 km, attraversando 13 paesi; 40 sono le notti passate in tenda, 11 quelle in cui mi hanno ospitato e sei quelle in cui ho alloggiato in piccole guest house.
Tenendo fede alla promessa che mi ero fatto, ho semplicemente suonato al citofono di casa per farmi aprire dai miei genitori! Cosa ho imparato? Che il mondo è migliore di come ci viene raccontato e c’è sempre chi è pronto ad aiutarci. E poi, che la bicicletta è come un passaporto che avvicina agli altri: la gente ha un atteggiamento diverso quando si viaggia sulle due ruote. Ma soprattutto ho imparato che non solo è possibile vivere con poco, ma anche salutare, per apprezzare comodità come un tavolo, un letto o l’acqua corrente. Così sono ripartito nell’estate 2024 per il Perù: dopo quattro mesi trascorsi a dare lezione di italiano, ho tentato la traversata delle Ande, con l’obiettivo di raccogliere fondi per un’associazione.
È stata durissima: ho trovato la stagione delle piogge e non era fattibile pedalare sotto l’acqua battente tutto il giorno. Non sono riuscito a concludere tutto il percorso che avevo in mente, ma conservo i volti e le voci di chi mi ha aiutato. In tanti mi chiedono cosa si provi a viaggiare come me: un grande, grandissimo senso di libertà. La mente si apre e apprezza altre culture, soprattutto se si viene da un contesto urbano, in cui i ritmi sono scaditi dal lavoro e non c’è connessione con la natura. Prossimi obiettivi? A breve sarò in Senegal, con un progetto di microcredito ed economia sostenibile, a novembre discuterò la tesi. Dopo di che, andrò dove mi porterà… la bicicletta!●
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Testo pubblicato su Confidenze n 35/2025