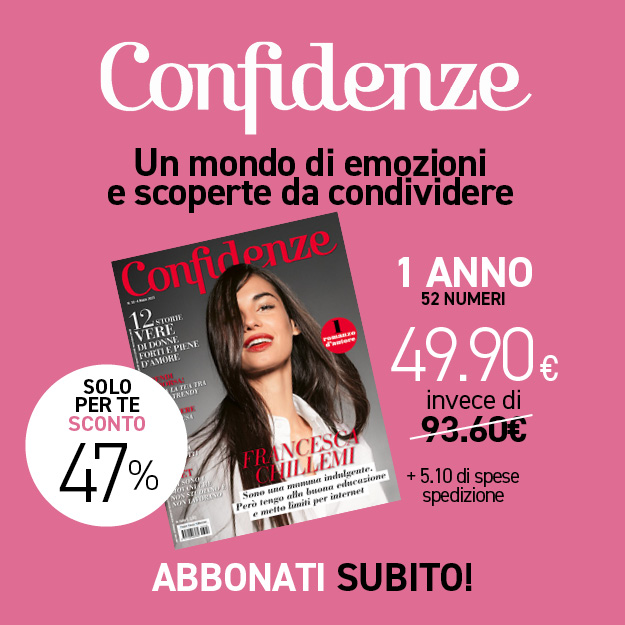Nella sua natura è un ormone, che viene secreto fisiologicamente dalla nostra ghiandola pineale nelle ore serali e regola i ritmi sonno-veglia. Ma la melatonina è anche uno degli integratori più utilizzati al mondo per favorire il sonno. La sua popolarità è cresciuta sia per la percezione di un’ottima sicurezza d’uso, sia per la possibilità di reperirla senza ricetta in molti Paesi, incluso il nostro.
Nelle ultime settimane, però, ha attirato grande attenzione un nuovo e ampio lavoro scientifico presentato alle Scientific Sessions 2025 dell’American Heart Association (la più grande organizzazione al mondo dedicata alla lotta alle malattie cardiovascolari e all’ictus), che ha puntato l’indice contro la melatonina. Lo studio riporta una correlazione tra uso cronico di melatonina e un maggior rischio di insufficienza cardiaca e mortalità.
La ricerca ha analizzato le cartelle cliniche di 130.000 adulti con insonnia cronica, che avevano dichiarato l’uso di melatonina per oltre un anno, confrontandoli con coetanei insonni che non l’assumevano. I risultati mostrano numeri allarmanti negli utilizzatori di melatonina per periodi prolungati: un rischio di insufficienza cardiaca aumentato del 90%, una probabilità di ricovero per insufficienza cardiaca di 3,5 volte superiore e una mortalità quasi doppia. Cifre che hanno fatto sentenziare agli autori dello studio che “la melatonina potrebbe non essere così innocua come si crede”.
Dobbiamo allora allarmarci e dimenticare per sempre la melatonina? Probabilmente no. Innanzitutto, si tratta di uno studio di tipo osservazionale e non invece sperimentale. Gli studi osservazionali, pur importantissimi, non possono, per loro natura, dimostrare un nesso di causa-effetto (che invece possono investigare gli studi sperimentali), ma solo correlazioni. Il motivo è semplice: negli studi osservazionali non si possono tenere sotto controllo le variabili esterne e quindi i partecipanti vivono la loro vita reale, con malattie, abitudini e fattori nascosti, che possono spiegare l’associazione. Quindi non è possibile stabilire che sia stata la melatonina a causare l’esito osservato, invece di altri fattori non noti né men che meno misurati.
Ulteriori criticità, poi, emergono analizzando lo studio in profondità. I più importanti? Mancano informazioni sul dosaggio di melatonina assunto e sulla reale continuità del trattamento. Per giunta, la ricerca nemmeno riporta dettagli sulla gravità dell’insonnia e sulla contemporanea presenza di disturbi psichiatrici, ansia e depressione, che sono tutti fattori collegabili sia all’uso di melatonina sia al rischio cardiovascolare.
Insomma, benché lo studio abbia preso in considerazione un grande campione, soffre di molti limiti metodologici. Ben vengano futuri, ulteriori approfondimenti, allora. Nel mentre, per quanto mi riguarda, continuerò a suggerire la melatonina ai miei pazienti che ne hanno necessità: la normativa europea limita il dosaggio degli integratori a 1 mg per compressa, favorendone un uso ragionato e controllato. Eviterei tuttavia le assunzioni “a vita”, senza soluzione di continuità, che sconsigliavo anche prima di questo studio, per la melatonina e, tendenzialmente, per qualunque altro integratore o rimedio naturale.